
Dall'antologia di racconti a scopo di beneficenza scritti per il libro "Storie" a cura di Nadine Gordimer
ReadBabyRead #98 dell'8 novembre 2012
Susan Sontag: "La scena della lettera" (1/2)

Susan Sontag
La scena della lettera (brani, parte 1 di 2)
per info su Franco Ventimiglia e Claudio Tesser:
Lettura e altri crimini
Legge: Roberta Borghi
A proposito di Susan Sontag
Un’icona per l’America della contestazione
“Guardare una vecchia fotografia di se stessi, o di una persona che si conosce, o di un personaggio pubblico molto fotografato, significa per prima cosa pensare: quanto più giovane ero (o era) allora” (Susan Sontag, “Sulla fotografia”).
Fra le immagini di protesta, che Fred McDarrah scatta nell’America degli anni Sessanta e Settanta, ve n’è una che ritrae una giovane donna condotta via da un poliziotto con in mano uno sfollagente; la ragazza, che avanza tranquilla e sorridente stringendo al petto un fascio di giornali, è Susan Sontag: si trova davanti alla Casa Bianca ed ha trentaquattro anni; è il 5 Dicembre 1967.
Dalla pubblicazione del saggio “Notes on Camp” nel ’64 ha un posto di primo piano fra gli intellettuali newyorkesi e, come Noam Chomsky, è apertamente schierata nel dibattito morale contro la guerra in Vietnam.
Riguardo alle circostanze dell’arresto immortalato, l’immagine in questione non rivela nulla più che il fatto in sé e la singolare espressione, quasi divertita, del volto della Sontag.
Si prova uno strano effetto davanti a questa istantanea, vedendo la celebre intellettuale ancora priva dell’attributo iconografico della sua ciocca bianca – che del resto sarebbe svanita fra la capigliatura uniformemente ingrigita degli ultimi anni –, qui riconoscibile più che altro per quell’intrigante, tipico sorriso, che la contraddistinguerà nella maggior parte dei ritratti successivi.
“L’osservatore sente”, come ha scritto Walter Benjamin, “il bisogno irresistibile di cercare nell’immagine quella scintilla magari minima di caso, di hic e nunc, con cui la realtà ha folgorato il carattere dell’immagine, il bisogno di cercare il luogo invisibile in cui, nell’essere in un certo modo in quell’attimo lontano si annida ancora oggi il futuro, e con tanta eloquenza che noi, guardandoci indietro siamo ancora in grado di scoprirlo”. E sembra quasi di poter carpire attraverso una simile immagine l’essenza più reale di Susan Sontag, non ancora alterata dalle stilizzazioni del ruolo d’icona culturale impostole dai media.
Sembra, addirittura, di poter leggere qui il suo vero senso di sé e la sua passione civile, più che nei suoi scritti.
E’ ovviamente un’illusione. Di quanto indebita fosse la reputazione goduta dalla fotografia in quanto presunta portatrice d’evidenze e inoppugnabili testimonianze, del resto, proprio lei ha scritto, tracciando acutamente i limiti di questa e mettendoci in guardia contro la sua reale natura di “medium” e contenitore neutro di messaggi, puro significante aperto ai più disparati usi e consumi: “come un caminetto a legna in una stanza, le fotografie – soprattutto quelle di persone o luoghi lontani, di città remote, di un passato svanito – sono incitamenti al fantasticare”.
Era nata a New York il 16 Gennaio del 1933 da una famiglia ebrea d’origine polacca e cresciuta fra Tucson e Los Angeles. Suo padre, Jack Rosenblatt, sempre lontano a causa del suo lavoro di commerciante di pellicce, era morto di tisi in Cina quando lei aveva solo cinque anni. Il cognome Sontag era quello dell’uomo che la madre aveva sposato sette anni dopo; sebbene egli non avesse mai adottato né lei né la sorella Judith, Susan aveva fatto proprio quel cognome, perché suonava bene, “meno buffo, meno ebraico, che Rosenblatt; più americano”, e consono a un’America postbellica largamente antisemita.
Ritenuta una sorta di bambina prodigio, avendo iniziato a leggere all’età di tre anni, aveva sviluppato una grande passione per la lettura, che mai l’aveva abbandonata: “leggere un libro era come entrare in uno specchio”, avrebbe detto più tardi. Adolescente, aveva sognato di diventare scrittrice, poiché, citando Ibsen: “scrivere è arrogarsi il diritto di giudicare se stessi”.
Sorretta da una vivace curiosità e da una straordinaria memoria, aveva intrapreso gli studi universitari a sedici anni. Preso il Bachelor of Arts al College dell’Università di Chicago, si era specializzata in Filosofia, Letteratura e Teologia presso la Harvard University e aveva vinto nel ’57 una borsa di studio per il Saint Anne’s College di Oxford; aveva poi frequentato anche il celebre ateneo di Parigi, a lei più congeniale, l’influenza della cui impostazione, le avrebbe in seguito fruttato una fama di intellettuale “european-style”.
Nel 1959 il suo matrimonio con il docente di sociologia Philip Rieff – da cui nel ’52 aveva avuto il figlio David, ora noto scrittore -, durato nove anni, si concludeva col divorzio. Ancora nel fior degli anni, Sontag si trovava a cominciare una nuova vita, avendo realizzato quanto l’ambiente universitario di Chicago fosse stato opprimente per lei e le sue aspirazioni, che stentavano ancora a prender una chiara forma; si era trasferita allora col figlio nella città natale, New York, dove aveva vissuto all’inizio in ristrettezze economiche, lavorando presso la Columbia University, come insegnante di Storia della Religione.
Ben presto però aveva iniziato a scrivere saggi per il famoso “Partisan Review”, il più influente giornale letterario d’America, orientato verso la sinistra e noto per aver lanciato vari scrittori ed intellettuali, principalmente d’origine ebraica. E proprio sul “Partisan” nell’autunno del ‘64 era apparso il già citato “Notes on Camp”.
Le sue prese di posizione “anti-accademiche” e il suo modo di scrivere semplice e diretto, l’avevano subito resa interprete ideale dei fermenti di quel particolare momento storico, e complice l’attenzione dei media in un periodo, come quello degli anni Sessanta e del primo femminismo, “alla disperata ricerca di un volto femminile”, Susan Sontag era divenuta presto arbitro del gusto e guida per l’opinione pubblica degli anni della contestazione.
Un’intellettuale antiaccademica
Le riflessioni sul Camp, dedicate ad Oscar Wilde e scritte in forma d’appunti, danno a Sontag un’improvvisa notorietà: definendo questa forma di sensibilità “inconfondibilmente moderna”, questo gusto snob per l’artificio e l’eccesso, “distintivo di riconoscimento tra piccole cricche urbane”, come una sorta di moderno dandismo, che afferma l’esistenza di “un buon gusto del cattivo gusto”, la scrittrice colpisce immediatamente l’immaginazione di un pubblico che va al di là degli addetti ai lavori.
Lo stile epigrammatico asciutto – che sempre caratterizzerà i suoi scritti, sia pure in una forma più distesa e riflessiva – si presta in quel momento ad un largo successo, ma anche a letture superficiali, che faranno etichettare il saggio come un trattato sull’estetica omosessuale e ne ridurranno i molti spunti possibili allo slogan: “è bello, perché è orribile”.
In realtà, in quelle argomentazioni c’è molto più; c’è il preludio del sistematico attacco che l’intellettuale americana avrebbe sferrato contro la critica tradizionale – da lei tacciata d’eccessivo intellettualismo – nella raccolta di saggi pubblicata l’anno dopo.
Se, infatti, negli appunti sul Camp si era limitata a descrivere un particolare gusto, e ad affermare che il gusto “governa ogni libera reazione umana, usando l’aggettivo ‘libera’ in contrapposizione all’aggettivo ‘automatica’”, e che “la sensibilità dell’alta cultura non ha il monopolio della raffinatezza”, con il suo “Against interpretation” si sposta più decisamente verso una “estetica dei sensi”.
Proclama la necessità di una lettura immediata, non ermeneutica ma “erotica” dell’arte: “ciò che è importante ora è riscoprire i nostri sensi. Dobbiamo imparare a vedere di più, ad ascoltare di più, a sentire di più”; queste asserzioni vengono recepite da molti come un tentativo di appropriarsi della rivoluzione sessuale per trasformarla in teoria estetica. E siffatta teoria viene applicata indifferentemente a testi letterari o artistici nel senso più ampio e vario: da Artaud ad Harpo Marx, da Sartre ai romanzi di fantascienza.
Gli interessi di Sontag, infatti, sin da allora sono variegati, e la inducono a soffermarsi su ogni genere di comunicazione contemporanea, indagandone l’impatto sulla società.
In una serie di saggi, dapprima pubblicati su “The New York Review of Books”, decide di indagare “certi problemi, estetici e morali, posti dall’onnipresenza delle immagini fotografate”. Ne verrà fuori nel ’71 il libro “On Photography”, pietra miliare nella riflessione sul linguaggio fotografico.
Fino ad allora gli studi sull’argomento erano stati pochi, e punto di riferimento nell’indagine sontagiana sulla fotografia è sicuramente Walter Benjamin, la cui analisi sociologica viene da lei ampliata e superata, mettendo oltretutto in luce le contraddizioni, provocate dall’attrito fra la sensibilità surrealista, soffusa d’ironia, e i principi moralisti, marxisti e brechtiani, dell’autore tedesco. Di Benjamin, Sontag rivela pure la passione di collezionista di citazioni, che “sembra una versione sublimata dell’attività fotografica”, in quanto quest’ultima è vista come un modo di collezionare indiscriminatamente immagini; surreale, perché crea duplicando il mondo “una realtà di secondo grado, più limitata ma più drammatica di quella percepita dalla visione naturale”: una realtà parallela, attraverso la quale si ha un’illusoria sensazione di conoscenza e di potere.
Come Benjamin, fra l’altro, Sontag cita Atget quale precursore del surrealismo fotografico, per il suo “atteggiamento inflessibilmente egualitario di fronte a qualsiasi oggetto”, e per la predilezione verso soggetti marginali e bizzarri, tipica della corrente artistica promossa da Breton. E prende in esame l’opera di August Sander che – mentre agli occhi del tedesco, grazie alla contemporaneità rispetto al suo saggio, appare soprattutto carica di significato politico, perché sposta l’attenzione sulla funzione sociale piuttosto che estetica della fotografia – per l’intellettuale americana è rappresentativo di un interesse nuovo, neutrale e “pseudoscientifico”, verso il volto umano, scelto non più perché oggetto di celebrazione, o di curiosità verso le miserie e le stranezze (a tal proposito, fa riferimento anche a Diane Arbus), ma scelto con un intento che “partiva dal corretto presupposto che la macchina fotografica non può fare a meno di rivelare i visi come maschere sociali”.
Riguardo al valore della fotografia come ambiguo strumento di conoscenza, la scrittrice rimarca l’idea benjaminiana dell’opportunità della didascalia, “che”, com’egli afferma, “include la fotografia nell’ambito della letteralizzazione di tutti i rapporti di vita, e senza la quale ogni costruzione fotografica è destinata a rimanere approssimativa”. Riprende inoltre anche l’assunto che l’immagine fotografica non è solo tramite di comunicazione, ma anche “bene di consumo”, rilevando che “una società capitalistica esige una cultura basata sulle immagini. Ha bisogno di fornire quantità enormi di svago per stimolare gli acquisti e anestetizzare le ferite di classe, di razza e di sesso”.
Non soltanto “oppio dei popoli”, tuttavia, la fotografia trova pieno riscatto già in Benjamin come medium capace di allargare il nostro “inconscio ottico” e la nostra ricettività visiva e, di conseguenza, la possibilità di comprendere. In Sontag arriva infine ad essere risorsa contro il nostro sempre più acuito “senso oppressivo della caducità di ogni cosa”: le immagini consumano ma, in qualche modo, rigenerano la realtà, divenute esse stesse reali. A questo punto urge, però, una “ecologia delle immagini”.
Non diversamente da quello che era avvenuto negli scritti precedenti, in “On Photography” la scrittrice esamina l’argomento trattato in una molteplicità d’aspetti, qui difficili da esaurire, proponendo una personale visione antidogmatica.
Un essere umano morale
L’ultima opera di Susan Sontag, “Regarding the Pain of Others”, esce nel 2003; e, malgrado sia stata da lei pensata soprattutto come un “libro sulla guerra”, ai nostri occhi appare come un ulteriore chiarimento del suo pensiero sulle problematiche inerenti alla comunicazione fotografica, a distanza di trent’anni dal suo primo libro sull’argomento.
L’estremo lascito ai suoi lettori è un’indagine sulla reale natura e sulla funzione delle immagini di guerra, e orrori simili, ma anche un monito sul ruolo a cui è chiamato chi poi le osserva, spesso comodamente seduto a leggere il proprio giornale.
Semina nell’animo di chi legge il dubbio, tanto sulla necessaria veridicità di questi documenti in quanto testimonianza – questione già dibattuta nel precedente libro -, quanto sullo scopo finale della pubblicazione di certe immagini (o della mancata pubblicazione di altre), affermando che “oltre che ad avvalorare, le immagini fotografiche di un’atrocità servono a illustrare… La valenza illustrativa delle fotografie lascia intatti pregiudizi, opinioni, fantasie e disinformazione”.
Secondo Sontag, “un evento diventa reale – agli occhi di chi è altrove e lo segue in quanto “notizia” – perché è fotografato”; e le immagini fotografiche, quali ci vengono quotidianamente e insistentemente proposte, a differenza di quelle in movimento (televisive o filmiche), “forniscono un modo rapido per apprendere e una forma compatta per memorizzare”, tanto che “la familiarità di certe fotografie plasma la nostra conoscenza del presente e del passato più recente”, e la loro ampia diffusione forma addirittura una memoria collettiva, che “eclissa altre forme di comprensione e di ricordo”.
La pretesa, nel pubblicare le fotografie di guerra, è sempre quella di testimoniare una realtà impensabile, suscitando il rigetto verso le sue brutture, ma “si possono fare molti usi delle innumerevoli opportunità che la vita moderna fornisce per guardare – a distanza, attraverso il mezzo fotografico – il dolore degli altri. Le fotografie di un’atrocità possono suscitare reazioni opposte. Appelli per la pace. Proclami di vendetta. O semplicemente una vaga consapevolezza, continuamente alimentata da informazioni fotografiche, che accadono cose terribili”, scrive l’autrice.
La manipolazione delle coscienze è sempre in agguato; lo shock provocato da certe immagini è destinato ad affievolirsi; lo spettatore è ridotto a semplice voyeur, stuzzicato nelle sue più intime e voluttuose paure, tranquillizzato dalla consapevolezza di una distanza fra lui e una sofferenza che non lo riguarda e, infine, non lo tocca intimamente.
Il quadro dipinto sembra quasi apocalittico, pesantemente influenzato com’è dalle opinioni politiche dell’ultima Sontag, che se già più volte ha sentito in passato l’obbligo morale di denunciare le storture del sistema, di recente è sempre più in aperta polemica contro il potere ed è sovente accusata di essere antipatriottica per le sue dichiarazioni riguardo alla politica imperialista di Bush, alla strumentalizzazione da parte di questi del terrorismo e alla creazione – grazie alla condiscendenza dei media – di un oscuro, quanto opportuno, nemico sopranazionale.
In realtà, questo scritto non si esaurisce in una presa d’atto delle problematiche messe in luce, secondo le quali tra l’altro le intenzioni del fotografo sono del tutto irrilevanti, né tanto meno si chiude con una requisitoria contro la fotografia di guerra. In conclusione, viceversa, essa acquista una valenza di memento e di stimolo morale, sebbene riemerga qui, come in passato, l’importanza della parola, quale antidoto a una polisemia, connaturata all’immagine fotografica, a causa della quale il contesto in cui la foto è esposta ne determina il senso più che il soggetto ritratto.
“E’ una narrazione che può farci capire. Le fotografie fanno qualcos’altro: ci ossessionano”, asserisce Sontag, ma aggiunge pure: “lasciamoci ossessionare dalle immagini più atroci… esse continuano ad assolvere una funzione vitale. Quelle immagini dicono: ecco ciò che gli esseri umani sono capaci di fare, ciò che – entusiasti e convinti di essere nel giusto – possono prestarsi a fare. Non dimenticatelo”.
Manca ancora il necessario distacco per valutare appieno la portata del lavoro intellettuale di Susan Sontag: troppo recente è infatti la sua scomparsa, causata dal cancro, che per due volte in passato aveva sconfitto, trasformando anche tale esperienza in oggetto di riflessione all’interno della sua analisi sui pregiudizi legati alla malattia pubblicata col titolo di “Illness as Metaphor”.
La sua opera è stata complessa per la varietà degli interessi, e controversa per la scelta di punti di vista sempre eccentrici rispetto alle posizioni canoniche.
Di molte cose si è occupata: ha scritto saggi e romanzi, è stata sceneggiatrice e regista di film, ha diretto importanti opere teatrali. In ognuna di queste attività ha cercato di esprimere sopra ogni altra cosa le sue qualità di “essere umano morale”, non meno che nelle sue battaglie a favore del Movimento di liberazione della donna, per i diritti umani, per la libertà d’espressione, contro le guerre in nome dei falsi ideali dell’imperialismo americano, e persino – senza troppe contraddizioni – a favore dell’intervento armato, inteso un po’ come il minore di due mali, per liberare Sarajevo dall’assedio serbo e porre fine ad una guerra fratricida.
Negli ultimi anni, riscoprendosi con i romanzi “The Volcano Lover” e “In America” soprattutto scrittrice, Sontag affermava: “La letteratura è una forma di responsabilità – verso la letteratura stessa e verso la società… Gli scrittori di narrativa seri pensano ai problemi morali praticamente… Stimolano la nostra immaginazione… Educano la nostra capacità di giudizio morale”.
Di sé aveva sempre parlato come di una “moralista ossessiva”. E, pur riservandosi lungo il corso dell’intera vita il diritto di cambiare idea su ogni argomento, mai è venuta meno al ruolo, scelto sin dagli esordi, di educatrice morale nella società.
Rosa Maria Puglisi
Le Musiche, scelte da Claudio Tesser
Orchestra Staatskapelle Dresden (Direttore Giuseppe Sinopoli, Soprano Alessandra Marc)
Tre frammenti dall'opera "Wozzeck": 2. Atto III, Scena 1 (Alban Berg)
Tre pezzi dalla "Suite Lirica": 1. Andante Amoroso (Alban Berg)
Logo di articolo:
una foto della giovane Susan Sontag (1975)
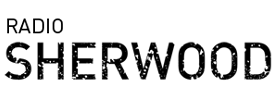
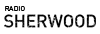
 loading...
loading...